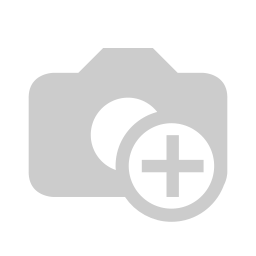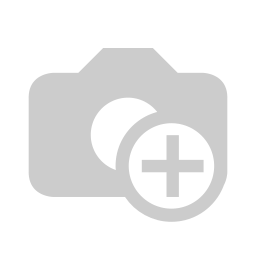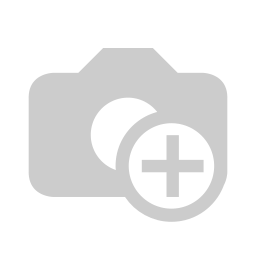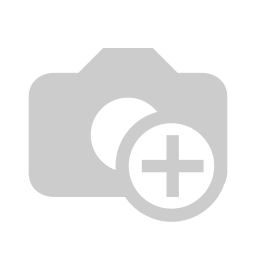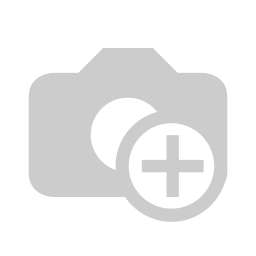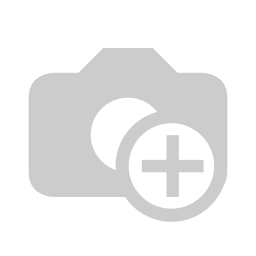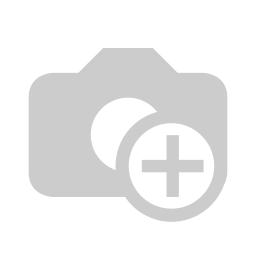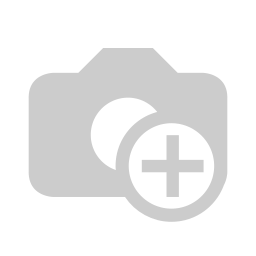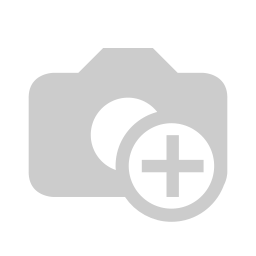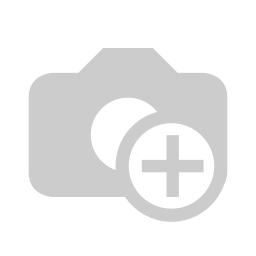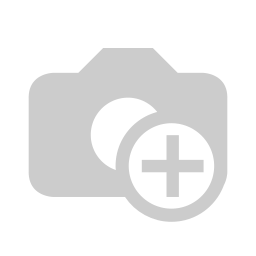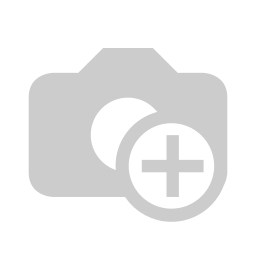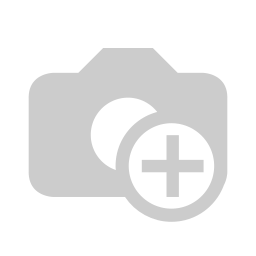Se vi capitasse di leggere qualcosa sulla pesca a mosca in Gran Bretagna prima o poi vi imbatterete di certo nel metodo North Country, che molti degli autori descrivono semplicemente come la pesca con gli spider, limitandosi a dirvi come costruire le mosche per il loro tratto di fiume preferito. Ma c’è molto di più riguardo al metodo North Country di quanto la maggioranza delle persone possa immaginare; sono cresciuto pescando con questo metodo e posso assicurare che funziona quasi dappertutto, anche se non posso scommettere che funzioni anche per catturare bonefish. Il North Country era una volta formato dalle contee di Westmorland, Cumberland, Durham, Yorkshire e Northhumberland, ma i confini e i nomi sono cambiati nel tempo. Oggi potrebbe essere descritto come tutto quello che sta a Nord di una linea che corre da Est a Ovest dall’estuario dell’Humber, lungo il fiume Wharfe e poi a Ovest attraverso il fiume Lune. I confini a Est e Ovest sono le coste, mentre il limite Nord è il confine scozzese. Non vi è nulla di ufficiale in questa definizione e, se fossimo in un pub, ci sarebbero innumerevoli discussioni su dove esattamente siano i confini a Sud e se Sheffield sia dentro o fuori, incluso il Lune, il Derwent e l’Eskin Cumbria, l’Eden, l’Aln, il Coquet, il Tyne, il Wear, il Tees, l’Esk in Yorkshire, e il bacino dell’Ouse/Ure, nel quale si riversano il Derwent dello Yorkshire, il Wharfe, il Nidd e lo Swale.

Nessuno di questi fiumi è particolarmente ampio e su quasi tutto il loro corso un lanciatore medio può raggiungere facilmente la sponda opposta e, mentre alcuni hanno tratti a corrente lenta, la maggior parte di loro ha fondo ciottoloso su tutto il percorso. Gli sfarfallamenti tendono a essere lievi e nonostante si vedano in giro diverse effimere le schiuse su questi fiumi sono principalmente di plecotteri, tricotteri e, oggigiorno, inevitabilmente di onnipresenti moscerini. Sorprendente anche per chi conosce la zona è il fatto che nel North Country ci sono anche alcuni chalk streams, come il Driffield west beck, il Costa beck e il Cod beck. Non ho idea di come quest’ultimo abbia preso tale nome, in quanto di sicuro non nuota nessun merluzzo (cod) nelle sue acque, nemmeno una bottatrice, ma resta il fatto che è chiamato proprio Merluzzo. Di tutti questi, il Driffield west beck ha la migliore reputazione e i permessi per pescarvi costano parecchio.
La pesca a mosca secca non ha nulla a che vedere con lo stile North Country e parecchie discussioni si sono susseguite tra le pagine della stampa specializzata durante la fine del XIX secolo per provarlo. In pratica ognuna di queste discussioni verteva sempre sullo stesso punto, cruciale in tutta la filosofia di pesca a mosca del North Country, che sostiene che con questa tecnica non si lancia ad un pesce in particolare, ma piuttosto la mosca viene appoggiata in punti ritenuti validi mano a mano che il pescatore procede verso monte. Questo approccio faceva infuriare i pescatori a mosca secca, ma se voi aveste pescato su un fiume del North Country capireste come le poche schiuse non incoraggino ad un approccio del tipo osserva e aspetta. In pratica, un buon pescatore con un minimo di tattica che ritiene possa esserci una trota dietro a quel rigiro d’acqua fra le rocce, può riuscire a catturarla con una semplice passata di pochi centimetri senza dragaggio, sicuramente meglio di chi si mette ad aspettare la prossima bollata, che può richiedere parecchio tempo prima che avvenga.
Come ogni pescatore italiano può facilmente capire, i pesci selvatici in torrente devono affidarsi al loro ingegno e il cibo è così scarso che non potranno mai raggiungere la densità di popolazione di un fiume alcalino. Quando un classico pescatore del North Country si appresta a risalire il fiume, userà una lunga canna, dieci piedi, anche dieci e sei a volte, sollevando la coda e riposandola con un ritmo chiamato in passato whipping, alzerà la punta della canna mentre la mosca viene verso di lui per mantenere in tensione la coda. Ogniqualvolta noterà un movimento strano, ferrerà; ad ogni piccola esitazione del finale, ferrerà; ad ogni sussulto di vento, ferrerà; ogni volta che una volpe scapperà a 300 metri da lui, ferrerà; quando glielo dirà l’istinto, ferrerà. Solo due cose sicuramente non farà e sarà sedere su una comoda panchina su un prato rasato su una dolce sponda (non ve ne sono comunque) e fare troppi falsi lanci, che spaventano il pesce come in qualunque altro luogo, incluso un bel fiume calcareo.
I ragazzi di una volta, tutti morti oggi, purtroppo, estraevano abbastanza coda dal mulinello all’inizio della giornata per fare i primi lanci e ci si poteva scommettere avessero la stessa coda fuori al termine della pescata. Ci vuole tempo per abituarsi a questo modo di pescare, ma con le giuste condizioni, specialmente quando si usano piccoli spiders nella pellicola superficiale, questa tecnica è pura dinamite. Ovviamente non è pesca a mosca secca, ma piuttosto un misto tra ninfa e pesca con emerger, dipendentemente da quanto lasciamo scendere la mosca in profondità. Ma dal momento che nessuno degli antichi pescatori del North Country sapeva cosa fosse una ninfa, non si può certo ritenere, come qualcuno ha suggerito recentemente, che siano stati loro a scoprire la pesca a ninfa. Se l’avessero fatto ciò sarebbe stato sorprendente, ma nonostante il fatto che le ninfe furono identificate nel XVII secolo e illustrate nel XVIII, fin quasi all’inizio del XX secolo i pescatori hanno ritenuto che gli insetti che il pesce mangiava cadessero in acqua inevitabilmente dal cielo, e quindi i North Country spiders furono costruiti per rappresentare spinner e dun travolti dalla corrente. Niente di tutto ciò importava ovviamente al pesce, è logico, dal momento che nessuno gli ha attribuito cognizioni scientifiche.
Ora che abbiamo toccato aspetti generali della storia del metodo North Country, vale la pena dargli uno sguardo più in profondità. Esistono un paio di libri sull’argomento che vale la pena leggere se voleste esplorare di più l’argomento, ma purtroppo sono entrambi fuori stampa: il primo è A Handbook of North Country Trout Flies di Roger Fogg; il secondo è Fly Fishing: The North Country Tradition di Leslie Magee. Noterete l’assenza del recente libro di Robert Smith, The North Country Fly: Yorkshire’s Soft Hackle Tradition e la ragione principale è che sebbene la sezione del libro di Smith sul metodo di pesca non sia troppo male, la prima metà del libro è piena di così tanti errori e supposizioni da risultare completamente inaffidabile. Per quanto riguarda i lettori italiani l’ipotesi più assurda che Smith fa è a pagina 3, dove scrive: "Con tutta probabilità, i primi esempi di mosche North Country furono importate in Inghilterra dai Romani, e più tardi adottati sia dai monaci cristiani che dagli scalpellini francesi che (prima dello scioglimento dei monasteri dal 1536 al 1541) si erano stabiliti e avevano abitato i grandi centri monastici del Nord dal XI al XII secolo”.
Smith si lascia andare con entusiasmo su questo tema fantasticando che i pellegrini abbiano sparso mosche in giro per il North Country e che i monasteri del Nord sia fossero messi a commerciare lana con il resto d’Europa in cambio di altre mosche. “Da questo commercio derivano l’evoluzione e l’adattamento degli antichi esempi di mosca esistenti oggi, con nuovi materiali e dressing dall’Europa continentale. Ed è in questi antichi esemplari che ha origine la tradizione delle mosche North Country”. Se qualcosa di questo fosse vero allora gli italiani potrebbero vantarsi di essere gli antenati della tradizione North Country, il che sarebbe fantastico, ma purtroppo si tratta di una favola. Per iniziare, l’unica evidenza che i Romani abbiano mai pescato a mosca è basata sull’interpretazione di un singolo ambiguo riferimento di Marziale - di sicuro Aeliano menziona la pesca a mosca, ma parla dei macedoni e non dei romani. In secondo luogo, nonostante sia possibile che i soldati macedoni nell’esercito romano si portassero dietro le loro mosche durante i loro viaggio (ho fatto speculazioni a proposito proprio sul mio libro History of fly fishing), non c’è però evidenza che abbiano mai portato queste mosche nel Nord dell’Inghilterra.
Inoltre non esistono prove che i monaci abbiano mai pescato nel Nord dell’Inghilterra o che abbiano scambiato beni con mosche; al contrario, erano soliti tenere carpe e altri pesci in piccoli stagni da dove li prelevavano con le reti. In quarto luogo, come il metodo Valsesiano al quale si riferisce Smith sia riuscito a trasferirsi nel Nord dell’Inghilterra, quando non era nemmeno conosciuto in tutta la penisola Italiana, rimane un mistero. Ma anche se ciò fosse successo non spiegherebbe perché le attrezzature e le mosche del North Country siano così diverse da quelle antiche Italiane. Per finire, il titolo di Robert Smith, The North Country Fly: Yorkshire’s Soft Hackle Tradition evidenzia la più grande delle imperfezioni del libro. Mi riferisco all’ignorare tutto il resto dei territori del Nord per costruire una storia intorno al fiume Wharfe e allo Yorkshire. Questa non intende essere una recensione del libro di Smith, ma piuttosto un appunto sul fatto che sia completamente inaffidabile dal punto di vista storico, perché esaminando le conoscenze dal lato documentale è chiaro che non si ha la più pallida idea della storia reale della pesca a mosca nei territori del Nord prima dell’inizio del XVIII secolo.
Dopo quella data esistono numerosi manoscritti contenenti liste di mosche, a iniziare da quello scritto nel 1712 da William Lister. Questi manoscritti potrebbero essere ancora più interessanti se non fosse per il fatto che i loro autori copiarono da scritti precedenti ormai perduti, alcuni dei quali provenienti da altre regioni, e tra loro stessi. Il motivo per il quale così tanti di questi manoscritti sono sopravvissuti è che c’era una notevole scarsità di libri sulla pesca a mosca nel Nord e questa circostanza spinse i pescatori a scrivere le proprie ricette a mano. Per immaginare la quantità di manoscritti che furono compilati a quel tempo pensate che mediamente solo un 1% è sopravvissuto fino a noi. Il primo libro sul metodo North Country, The North-Country Angler, fu pubblicato a Leeds nel 1786, fu ristampato nel 1789, 1800 e 1817, ma non conteneva nulla di simile ad una lista di mosche. Altre opere del periodo sono The Driffield Angler di Alexander Mackintosh, pubblicato nel 1806, e The Northern Angler di John Kirkbride, pubblicato nel 1837, ma nonostante siano importanti per la bibliografia del North Country, nessuno dei due contiene interessanti informazioni per i pescatori con gli spiders. I libri che invece sono considerati oggi quelli più importanti sono The Practical Fly Fisher di John Jackson del 1854, a seguire con Yorkshire Trout Flies di Thomas Pritt del 1885 e per finire con Brook and River Trouting di Harfield Henry Edmonds e Norman Nellist Lee del 1916. Esistono poi altri autori interessanti, ma rischiamo di dilungarci troppo.
La parte più interessante della tradizione della pesca a mosca con il metodo North Country sono proprio le mosche alle quali abbiamo accennato sopra, conosciute ovunque come spider, o più recentemente come soft hackles, grazie a Sylvester Nemes. Resta il fatto che nessuno di questi nomi è propriamente corretto, in quanto esistono numerosi esempi di mosche costruite con piume soffici che non hanno nulla a che vedere con il North Country, e molte altre ancora che vengono chiamate normalmente spider, come le mosche di William Stewart. Un termine più appropriato potrebbe essere game hackle flies (mosche con piumaggio di selvaggina), in quanto la caratteristica peculiare di questi modelli del North Country è di essere costruiti con piume prelevate da selvaggina, in particolare da tipi di pernice, beccaccia, beccaccino, piviere, tutti molto abbondanti nel Nord dell’Inghilterra. Una volta che si inizia a comprendere questa sfumatura diventa facile distinguere uno spider North Country da uno spider di Stewart, perché le mosche scozzesi erano per lo più montate con piume provenienti da volatili di poco interesse per la caccia, come starne, landrail (re di quaglie, o gallinella terrestre, Crex crex) e dotterel (piviere tortolino, Charadrius morinellus). L’unica eccezione ai piumaggi da selvaggina nelle mosche North Country è la gallinella d'acquache non era certo una preda ricercata dai cacciatori..
Oggigiorno la tendenza è di costruire queste mosche con piume di selvaggina montate molto rade, con corpi il più sottili possibile in seta o dubbing, con hackle avvolte con un giro o un giro e mezzo al massimo. Resta il fatto che comunque i vecchi maestri non imposero mai alcuna rigida regola su questo punto e costruirono le loro mosche perché fossero durevoli nel tempo. Il risultato, come mi fece notare un amico, non assomiglia a nessun tipo di insetto, ma, credetemi, funzionano alla grande e diventano ancora più efficaci quante più fibre del collarino di hackle perdono con l’uso. Il problema principale con questo tipo di montaggio è trovare piume piccole abbastanza per costruire su ami del 14 e 16, perché la maggior parte dei commercianti fa fatica a credere che qualcuno possa essere interessato a piume di pernice più corte di 4 cm. La soluzione migliore resta quella di acquistare pelli intere in quanto le piume più adatte al nostro scopo si trovano proprio sul collo e raramente sono le piume che finiscono nelle bustine vendute nei negozi. Quando è costruita correttamente, una mosca in piuma di selvaggina assomiglia ad una cosa informe, ma nell’acqua riesce a prendere vita. Sono mosche che lavorano magnificamente e le ho usate con successo in varie parti del mondo. Una delle cose che crea più confusione tra le mosche in stile North Country è che la maggioranza dei primi esempi fu chiamata con il nome locale dell’insetto che rappresentava, con l’inevitabile risultato che diversi artificiali finirono per avere nomi simili e vi furono frequenti duplicati di ricette. Per complicare ancor più la cosa, nessuno di questi nomi locali era scritto in maniera simile e i dialetti dei territori del Nord usavano parole che difficilmente finivano nei dizionari, e da qui l’enorme confusione.
Tempo fa collaborai con l’Oxford English Dictionary come consulente e mi interessai della cosa. Ad esempio due delle parole più comuni nelle liste di mosche del tempo sono bloa e watchet. In effetti esistono molte mosche del North Country che contengono la parola "bloa" nel nome e parecchie sciocchezze sono state scritte da improvvisati autori circa l’origine del termine, ma è risaputo da anni che la parola deriva dall’Inglese “blo” e dallo scandinavo “blà”, che si riferisce al blu scuro, il colore simile al pelo della schiena della talpa. I territori del Nord furono un tempo dominati dai Vichinghi e si è ereditata la forma “blà”, rivista in Scozia come "blae" e nel nord dell’Inghilterra come Bloa. Questo rende più interessante il fatto che alcuni scrittori hanno usato nei primi manoscritti del Nord la forma Bloe che implica che alcuni dei modelli di mosche che copiarono avevano chiaramente origini del Sud dell’Inghilterra. E che dire del termine "watchit", che generalmente indica un colore blu tenue; l’uso di questa parola risale al francese antico e deriva da un tipo di indumento. Il problema è che quando le parole "bloa" o "watchet" venivano usate per un modello di mosca del North Country, si riferivano sempre alla tonalità di blu delle ali dell’insetto naturale, piuttosto che al colore usato nell’artificiale. Non sorprende quindi che pochissimi artificiali contengano blu nella ricetta di costruzione.
Tutto questo iniziò a cambiare durante il XIX secolo, in quanto i vecchi dialetti iniziarono a morire, i nomi delle mosche del North Country si modernizzarono e le mode sulla costruzione di artificiali cambiarono. Ad esempio la vecchia Snipe Blo diventò la Snipe and Yellow, o la Deel Cruik, che cambiò nome in Woodcock and Yellow. Sarebbe stato molto più semplice se Charles Cotton fosse vissuto nel Wensleydale e se un paio di buoni libri fossero stati pubblicati nel XVII secolo, ma è anche vero che ci saremmo privati, qui ed ora, dell’innocente divertimento di scoprire tutto ciò! Le piume di selvaggina restano comunque una piccola parte dei materiali usati nelle mosche North Country, ed esistono numerose ricette famose che richiedono l’utilizzo di volatili da cortile e gallinacei in genere. Come ad esempio la Treacle Parkin, una parente della Red Tag. La Treacle Parkin è una mosca da temolo, ma, a dire il vero, una delle particolarità delle liste di mosche del North Country è che sono piene di artificiali per la pesca al temolo, pesce che era comune quanto la trota, a quel tempo. Questo articolo rischia di proseguire all’infinito e suppongo di dover chiudere qui, ma lasciatemi aggiungere un piccolo cenno ad un tipo di mosche che potrete notare su quelle liste, chiamate bustard. Bene, un materiale che sicuramente non vedrete mai su queste mosche è l’otarda (bustard) in quanto venivano costruite principalmente con gallina bianca o allocco. Il nome deriva semplicemente da grosse farfalle che diventano attive all’imbrunire e che vengono comunemente chiamate bustards.
Vi lascio ora con alcune ricette da provare; si tratta di artificiali presi dal libro di Edmonds and Lee, Brook and river trouting, che essendo stato pubblicato nel 1916 contiene una bella lista di mosche in stile North Country. Mi capitò anni fa di pescare per un intera stagione unicamente con questi quattro modelli e con ottimi risultati. Se li costruirete su ami in misura 14 e 16 non potrete sbagliare. Un piccolo consiglio che mi sento di dare è di usare ami particolarmente leggeri (ad esempio il Partridge Trout Spider L3A/S disegnato apposta per gli spider) in modo che la mosca lavori proprio nella pellicola superficiale. Ci saranno occasioni nelle quali il pesce diventa estremamente selettivo e se la mosca scende anche solo di un centimetro verrà invariabilmente rifiutata. Mentre altre volte verrà ignorata se NON affonderà almeno un centimetro. Dovrete quindi adattarvi come al solito alla situazione, un po’ più a galla oppure più sotto. Oppure se nulla funziona allora concedetevi un buon pranzo o semplicemente rilassatevi osservando un martin pescatore in azione.
Waterhen Bloa
Ali: hackle di colore grigio fumo dal sotto-ala di gallinella d'acqua (con la parte più scura della piuma rivolta verso la testa della mosca).
Corpo: seta gialla, con poco dubbing in pello di talpa.
Testa: seta gialla.
Snipe e Purple
Ali: hackle prelevata da un ala di beccaccino
Corpo: seta porpora.
Testa: seta porpora.
Orange Partridge
Ali: hackle screziata prelevata da un collo di pernice o dalla schiena.
Corpo: seta arancio con rigaggio di quattro giri di tinsel oro.
Testa: seta arancio.
Yellow Partridge
Ali: hackle di pernice leggermente screziata, prelevata dalla schiena.
Corpo: seta gialla.
Testa: seta gialla.
Edmonds and Lee la indica come imitazione di dittero, ma al pesce pare importare poco.
Pubblicato su Fly Line Numero 3 anno 2016
Ringraziamo l'editore Roberto Messori per la gentile concessione.